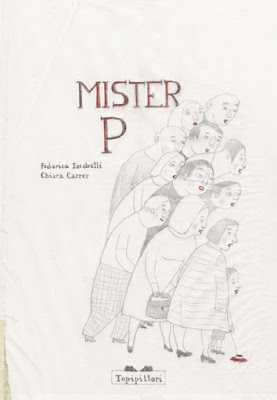di Bruno Tognolini, 2012
10,00 |
Acquistalo su Topishop
Un uomo e un cane stanno seduti sulla spiaggia a guardare il mare. «Di che colore è?» chiede il cane al suo padrone. L'uomo quasi senza pensare risponde che è blu, poi riflette e prova a esser più preciso, perché quello che ha accanto è un quadrupede pignolo e, soprattutto, molto filosofo. «È verde acqua, poi turchese, poi azzurro e solo alla fine è blu, blu oltremare.» L'animale allora invita l'essere umano a riempire una bottiglietta con un po' di quell'acqua e ad osservarne il contenuto. «È trasparente» dice l'uomo al cane che finalmente può abbaiare di soddisfazione. Oltre il mare, su un'altra spiaggia, c'è un bambino che ammira quella stessa grande superficie che sa di sale, cerca con gli occhi il futuro, immagina l'adulto che diventerà e ha pupille piene d'incanto. L'uomo con il cane vede il bambino, il bambino vede l'uomo con il cane: un incrocio di sguardi ed è doppio blu...
Bruno Tognolini, cagliaritano, celebrato "poeta per l'infanzia" (e non soltanto) e autore di programmi televisivi come
L'albero azzurro e
La Melevisione, racconta la sua infanzia, alternando a dialoghi tra se stesso e il cane frammenti del tempo in cui ha saputo forgiare il proprio mondo e l'adulto che è diventato. Perché il piccolo Bruno ha avuto il potere di dare il nome alle cose e di inventare un universo: a quelle luci che lievi entravano dalle finestre quando finiva la notte e si trasformavano in matasse luminose in movimento sul soffitto ha dato il nome di
Arie e ha fatto diventare la preghiera “Gesù mi metto nelle tue mani” una storia dove il protagonista era Gesù Mimetto. Ogni bambino ha una storia simile tra i ricordi, ma non sempre ne ha memoria perché durante la crescita non tutto va per il verso giusto. Capita a volte che i grandi deraglino dai binari così pazientemente preparati da se stessi quando erano bambini e magari chi voleva fare l'astronauta finisce immusonito e vestito di grigio dietro una scrivania, privo del bimbo che è stato. Tognolini non solo non è mai uscito da quelle rotaie, ma continua a costruirle, sfrecciandoci sopra con la velocità supersonica della sua fantasia.
Da
Doppio blu, recensione di Amarilli Novel, per il sito
Mangialibri.
Un
uomo ed un cane stanno seduti sulla spiaggia a guardare il mare. «Di
che colore è?» chiede il cane al suo padrone. L'uomo quasi senza pensare
risponde che è blu, poi riflette e prova ad esser più preciso, perché
quello che ha accanto è un quadrupede pignolo e, soprattutto, molto
filosofo. «È verde acqua, poi turchese, poi azzurro e solo alla fine è
blu, blu oltremare.» L'animale allora invita l'essere umano a riempire
una bottiglietta con un po' di quell'acqua e ad osservarne il contenuto.
«È trasparente» dice l'uomo al cane che finalmente può abbaiare di
soddisfazione. Oltre il mare, su un'altra spiaggia, c'è un bambino che
ammira quella stessa grande superficie che sa di sale, cerca con gli
occhi il futuro, immagina l'adulto che diventerà e ha pupille piene
d'incanto. L'uomo con il cane vede il bambino, il bambino vede l'uomo
con il cane: un incrocio di sguardi ed è doppio blu...
Bruno Tognolini, cagliaritano, celebrato "poeta per l'infanzia" (e non
soltanto) ed autore di programmi televisivi come L'albero azzurro e La
Melevisione, racconta la sua infanzia, alternando a dialoghi tra se
stesso ed il cane frammenti del tempo in cui ha saputo forgiare il
proprio mondo e l'adulto che è diventato. Perché il piccolo Bruno ha
avuto il potere di dare il nome alle cose e di inventare un universo: a
quelle luci che lievi entravano dalle finestre quando finiva la notte e
si trasformavano in matasse luminose in movimento sul soffitto ha dato
il nome di Arie e ha fatto diventare la preghiera “Gesù mi metto nelle
tue mani” una storia dove il protagonista era Gesù Mimetto. Ogni bambino
ha una storia simile tra i ricordi, ma non sempre ne ha memoria perché
durante la crescita non tutto va per il verso giusto. Capita a volte che
i grandi deraglino dai binari così pazientemente preparati da se stessi
quando erano bambini e magari chi voleva fare l'astronauta finisce
immusonito e vestito di grigio dietro una scrivania, privo del bimbo che
è stato. Tognolini non solo non è mai uscito da quelle rotaie, ma
continua a costruirle, sfrecciandoci sopra con la velocità supersonica
della sua fantasia. - See more at:
http://www.mangialibri.com/bambini-ragazzi/doppio-blu#sthash.oPmaF2R4.dpuf
Un
uomo ed un cane stanno seduti sulla spiaggia a guardare il mare. «Di
che colore è?» chiede il cane al suo padrone. L'uomo quasi senza pensare
risponde che è blu, poi riflette e prova ad esser più preciso, perché
quello che ha accanto è un quadrupede pignolo e, soprattutto, molto
filosofo. «È verde acqua, poi turchese, poi azzurro e solo alla fine è
blu, blu oltremare.» L'animale allora invita l'essere umano a riempire
una bottiglietta con un po' di quell'acqua e ad osservarne il contenuto.
«È trasparente» dice l'uomo al cane che finalmente può abbaiare di
soddisfazione. Oltre il mare, su un'altra spiaggia, c'è un bambino che
ammira quella stessa grande superficie che sa di sale, cerca con gli
occhi il futuro, immagina l'adulto che diventerà e ha pupille piene
d'incanto. L'uomo con il cane vede il bambino, il bambino vede l'uomo
con il cane: un incrocio di sguardi ed è doppio blu...
Bruno Tognolini, cagliaritano, celebrato "poeta per l'infanzia" (e non
soltanto) ed autore di programmi televisivi come L'albero azzurro e La
Melevisione, racconta la sua infanzia, alternando a dialoghi tra se
stesso ed il cane frammenti del tempo in cui ha saputo forgiare il
proprio mondo e l'adulto che è diventato. Perché il piccolo Bruno ha
avuto il potere di dare il nome alle cose e di inventare un universo: a
quelle luci che lievi entravano dalle finestre quando finiva la notte e
si trasformavano in matasse luminose in movimento sul soffitto ha dato
il nome di Arie e ha fatto diventare la preghiera “Gesù mi metto nelle
tue mani” una storia dove il protagonista era Gesù Mimetto. Ogni bambino
ha una storia simile tra i ricordi, ma non sempre ne ha memoria perché
durante la crescita non tutto va per il verso giusto. Capita a volte che
i grandi deraglino dai binari così pazientemente preparati da se stessi
quando erano bambini e magari chi voleva fare l'astronauta finisce
immusonito e vestito di grigio dietro una scrivania, privo del bimbo che
è stato. Tognolini non solo non è mai uscito da quelle rotaie, ma
continua a costruirle, sfrecciandoci sopra con la velocità supersonica
della sua fantasia. - See more at:
http://www.mangialibri.com/bambini-ragazzi/doppio-blu#sthash.oPmaF2R4.dpuf
Un
uomo ed un cane stanno seduti sulla spiaggia a guardare il mare. «Di
che colore è?» chiede il cane al suo padrone. L'uomo quasi senza pensare
risponde che è blu, poi riflette e prova ad esser più preciso, perché
quello che ha accanto è un quadrupede pignolo e, soprattutto, molto
filosofo. «È verde acqua, poi turchese, poi azzurro e solo alla fine è
blu, blu oltremare.» L'animale allora invita l'essere umano a riempire
una bottiglietta con un po' di quell'acqua e ad osservarne il contenuto.
«È trasparente» dice l'uomo al cane che finalmente può abbaiare di
soddisfazione. Oltre il mare, su un'altra spiaggia, c'è un bambino che
ammira quella stessa grande superficie che sa di sale, cerca con gli
occhi il futuro, immagina l'adulto che diventerà e ha pupille piene
d'incanto. L'uomo con il cane vede il bambino, il bambino vede l'uomo
con il cane: un incrocio di sguardi ed è doppio blu...
Bruno Tognolini, cagliaritano, celebrato "poeta per l'infanzia" (e non
soltanto) ed autore di programmi televisivi come L'albero azzurro e La
Melevisione, racconta la sua infanzia, alternando a dialoghi tra se
stesso ed il cane frammenti del tempo in cui ha saputo forgiare il
proprio mondo e l'adulto che è diventato. Perché il piccolo Bruno ha
avuto il potere di dare il nome alle cose e di inventare un universo: a
quelle luci che lievi entravano dalle finestre quando finiva la notte e
si trasformavano in matasse luminose in movimento sul soffitto ha dato
il nome di Arie e ha fatto diventare la preghiera “Gesù mi metto nelle
tue mani” una storia dove il protagonista era Gesù Mimetto. Ogni bambino
ha una storia simile tra i ricordi, ma non sempre ne ha memoria perché
durante la crescita non tutto va per il verso giusto. Capita a volte che
i grandi deraglino dai binari così pazientemente preparati da se stessi
quando erano bambini e magari chi voleva fare l'astronauta finisce
immusonito e vestito di grigio dietro una scrivania, privo del bimbo che
è stato. Tognolini non solo non è mai uscito da quelle rotaie, ma
continua a costruirle, sfrecciandoci sopra con la velocità supersonica
della sua fantasia. - See more at:
http://www.mangialibri.com/bambini-ragazzi/doppio-blu#sthash.oPmaF2R4.dpuf
 di Diego Malaspina, 2009
di Diego Malaspina, 2009